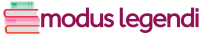Si parla molto di traduzione di un testo e il tema sembra finalmente avere assunto le dimensioni sufficienti a raggiungere l’immaginario dei lettori. Cos’era “quel” libro prima della sua traduzione? Quali sono gli strumenti a disposizione del traduttore?
Perché è chiaro che occorra restituire il testo originario creando lo stesso effetto emotivo e intellettuale, restando fedeli alla lingua ma avendo la capacità d’esecuzione più raffinata possibile.
Per parlare di tutto questo ci siamo rivolti a Daniele Petruccioli, traduttore dal portoghese, dal francese e dall’inglese, autore di due saggi sulla traduzione (Falsi d’autore” – Quodilibet e “Le pagine nere” – La Lepre Edizioni” e di un romanzo dal titolo “La casa delle madri” uscito per TerraRossa Edizioni; insegnante di Teoria della traduzione e Traduzione editoriale dal portoghese all’università “Unint” di Roma.
Con lui cercheremo di addentrarci nell’universo dei traduttori e di capire qualcosa in più su un settore importante, anello di congiunzione fondamentale nella filiera editoriale.
1) Qual è stato il segno tangibile della tua chiamata all’arte della traduzione?
Forse non parlerei proprio di una chiamata. Piuttosto una passione, un’incapacità di non prestare corpo e voce alle parole altrui. Ho cominciato col teatro, a cui mi sono dedicato prestissimo (a quindici anni facevo spettacoli di strada) e in cui ho lavorato, prima recitando e alla fine dirigendo una piccola compagnia di teatro di ricerca, per più di vent’anni, alla fin fine. Già allora traducevo, sotto un certo punto di vista. E traducevo anche in senso “classico”, volgendo in italiano testi teatrali e di poesia per la mia compagnia, traducendo copioni e sceneggiature per le compagnie primarie con cui collaboravo (a volte anche per qualche agente, se non ricordo male).
Nel frattempo mi ero laureato in lingua e traduzione e avevo cominciato a lavorare per qualche casa editrice. Nel 2008 ho deciso che non volevo più fare televisione, dove giravano e girano i soldi veri ma in cui si lavora in un modo che non mi piace e in cui non mi sono mai riconosciuto, e mi ero anche un po’ stufato di partire in tournée (visto che nel frattempo avevo fatto un figlio). Perciò ho chiamato il mio agente di allora per dirgli di non considerarmi più per i lavori cinetelevisivi e ho smesso di produrre spettacoli teatrali, così da dedicarmi alla traduzione editoriale a tempo pieno. Ecco, se proprio devo trovare un segno tangibile direi che è stata quella telefonata lì.
2) Cosa significa per te tradurre un libro?
Quello che significava il teatro: interpretare, dar voce. Far parlare gli artisti che ammiro attraverso il mio sguardo su di loro. In questo modo, mi sembra di partecipare al ricircolo della kalokagathia mondiale, che nel mio immaginario non rappresenta tanto l’eroe greco bello di fisico e di mente quanto piuttosto le cose belle e le idee buone dell’umanità. Mi fa sentire un relais della creatività generale.
3) Quali testi hanno sollecitato la tua vocazione nei confronti della traduzione?
Preferirei non parlare di vocazione, mi sembra una cosa troppo mistica. L’arte, come l’amore, è una cosa che si fa. Detto questo, personalmente vivo il concetto di traduzione in senso molto ampio. Per me davvero tutto è traduzione, non facciamo altro che tradurci e tradurre, è il fulcro di ogni espressione e comunicazione umana. Da questo punto di vista, tutti i libri che ho letto, a cominciare da Topolino e dal Giornalino di Giamburrasca fino ai dialoghi di Luciano passando per Proust e Dostoevskij, hanno una relazione profonda e indissolubile con la traduzione. Peraltro, per saper tradurre bisogna leggere tantissimo, altrimenti non si possiede il bagaglio testuale necessario.
Se però cerco di pensare a titoli che hanno illuminato il mio modo di guardare al mio mestiere, i primi che mi vengono in mente sono, da una parte, il racconto “La freccia nera”, da Tu sanguinosa infanzia di Michele Mari e, dall’altra, il saggio Oltre abita il silenzio. Tradurre e la letteratura di Enrico Terrinoni.
In mezzo, tutte le grandi traduzioni che ho letto, prima e dopo aver deciso di farlo di mestiere: dai romanzi di Pennac tradotti da Yasmina Mealouah (e intendo proprio tutti, a partire dal Paradiso degli Orchi) all’Anna Karenina di Claudia Zonghetti uscita per Einaudi solo quattro anni fa; dalla sintassi di Alice Munro secondo Susanna Basso alla Jane Eyre tradotta da Monica Pareschi nel ’14 per Neri Pozza.
Ma sopra a tutti, perché sono loro a dettare la rotta, ci sono gli scrittori italiani: dai classici ai contemporanei, dalla semplicità ricercatissima di Leopardi al gongorismo rigoglioso di Gadda, da Marco Lodoli con le sue parole calde ai cannibali con la loro imitazione ironica del doppiaggese… Da ognuno c’è da prendere qualcosa.
4) Quando uno scrittore si mette davanti al foglio bianco avendo comunque in testa la storia che scriverà, ciò di cui si preoccupa è il come narrarla, cerca il suo tono, la sua lingua. È la stessa cosa per un traduttore?
Non so per gli altri, perché ognuno ha la sua tecnica. Ti posso dire come lavoro io. Prima ho bisogno di ascoltare il testo. Lo leggo almeno una volta (anche se l’ho già letto) subito prima di cominciare a tradurlo. Se possibile due. Per farmi l’orecchio. Devo sentire come parla. Come canta, anzi, o se si preferisce come suona. Qual è il suo sound, al mio orecchio.
Poi, quando comincio, ogni giorno a fine lavoro rileggo quello che ho fatto, possibilmente a voce alta, e correggo – gli errori, certo, i calchi, le goffaggini di grammatica e sintassi; ma soprattutto il suono, che ormai mi sembra la cosa più importante. Poi, la sera, leggo le pagine che dovrò tradurre il giorno dopo. Per sentirle di nuovo.
Ti sembrerò un fissato, so che molti colleghi (bonariamente) lo pensano. Però, ogni volta che ne ho avuto l’opportunità, ho chiesto agli scrittori stranieri what mustn’t get lost in translation? (lo scrivo in inglese perché è un po’ la lingua franca anche per scrittori e traduttori, quando si incontrano in contesti plurilingue) e sempre, sempre, senza eccezione alcuna, mi hanno risposto the music. Chi sono io, per contraddirli?
5) Com’è vista nel nostro paese, secondo te, la figura del traduttore?
Per la maggior parte delle persone, purtroppo anche per alcuni scrittori, editori e critici, è uno scocciatore che non vedono l’ora di poter sostituire con un programma. La mia posizione è che, il giorno in cui quel programma riuscirà a fare quel che faccio io, gli diamo la cittadinanza.
Per fortuna le cose stanno cambiando soprattutto a livello della percezione diffusa da parte dei lettori. Anche grazie alle traduttrici e ai traduttori della mia generazione, lasciamelo dire con orgoglio, che si sono battuti e non smettono ancora di farlo perché alla traduzione sia riconosciuta l’importanza che si dà a ogni espressione artistica di tipo interpretativo. Un traduttore è un musicista – né più, né meno. Non un compositore, magari, o almeno non sempre, ma certo almeno l’equivalente di un grande esecutore. Io non saprei ascoltare Chopin senza Rubinstein, Bach senza Gould, Schumann senza Argerich, Beethoven senza Benedetti Michelangeli… Ciò detto, un pianista può essere grande e può essere scarso: sta a chi lo ascolta esprimere un giudizio. Da cui l’importanza fondamentale dei lettori, che per me sono il metro definitivo nel mio lavoro.
6) Cosa consideri come ferri del mestiere del traduttore?
Facile: lessico, grammatica e sintassi, punteggiatura. Però bisogna saperli usare fuori dalla banalità del “bello stile” anche di stampo alto, perché i grandi scrittori inventano la lingua e se non inventi anche tu non stai facendo bene il tuo mestiere (lo diceva già Leonardo Bruni nel Quattrocento). E allora bisogna leggere voracemente, tutto, qualsiasi cosa, anche quelle che non ci piacciono, che non sono “nelle nostre corde”. Senza un grande serbatoio di stili e linguaggi diversi in italiano, dal lessico stilnovista all’autofiction passando per modernismo e nouveau roman (in traduzione nostrana), è semplicemente impossibile avere il bagaglio necessario da cui attingere. Ma non basta. Bisogna imparare da Lutero e andare ad ascoltare anche come parlano gli italiani, da Torino a Taranto e dagli ambulanti della Vucciria agli amministratori delegati trapiantati a Londra.
Infine, una cosa che ho imparato da Katharine Hepburn: coltivare il proprio talento. Perché non basta avercelo, bisogna anche saperlo far crescere. E allora mi permetto sommessamente di consigliare a un aspirante traduttore di farsi pure un discreto bagaglio di storia e critica della letteratura, linguistica (soprattutto sociolinguistica e linguistica antropologica) e sì, anche teoria della traduzione. Così almeno saprà quello che fa, oltre a farlo. Che non sarà tutto, forse, ma rappresenta una bella marcia in più.
7) Ho sempre avuto una curiosità che spero potrai soddisfare: di cosa si accorge un traduttore che invece resta oscuro all’autore?
Se proprio devo essere sincero, ho una mezza idea che molti scrittori spingano sul lato oscuro solo per alimentare il mito dell’artista.
In realtà – credo – scrittori e traduttori entrambi, in quanto artisti, devono imparare ad affidare una parte del loro lavoro all’inconscio senza paura, ma anche senza falsi misticismi. Per me, scrivere e tradurre sono due cose molto simili. La differenza – a parte ovviamente nelle tecniche – sta forse più tra un traduttore e l’altro, tra uno scrittore e l’altro. Ci sono quelli che non rileggono niente e quelli che rileggono centomila volte. I maniacali e i disordinati. Chi deve sapere tutto prima e chi invece si butta.
Certo, nel lavoro del traduttore c’è una mediazione implicita, un secondo grado della scrittura, per così dire. È vero, per esempio, che per poter tradurre si deve cercare di capire al meglio ogni meccanismo (di trama, di stile…) di un libro. Però, dopo questa fase, per me come traduttore c’è anche quella in cui cerco di dimenticare tutto questo e di affidarmi all’intuito. Quando fai silenzio dentro, chiudi gli occhi, ricominci e vedi che succede. Secondo me sta qui il segreto di un bravo scrittore come di un bravo traduttore. La tecnica, lo studio, da soli non bastano. L’ispirazione, l’illuminazione da sole, nemmeno. Ci vogliono entrambi i versanti: luce e buio.
8) Secondo te cosa si aspetta il lettore tipo da una traduzione?
Sinceramente non me lo chiedo mai. Quel che mi chiedo e mi richiedo sempre è: cosa si aspetta questo libro da me come traduttore? Come posso fare per suonarlo al meglio? Se ci riesco, avrò fatto quello di cui ha bisogno il lettore tipo di quel libro, credo.
9) Com’è cambiato nel tempo il tuo rapporto con la letteratura grazie alla traduzione?
In nulla, nel modo più assoluto. Piuttosto il contrario. È l’evoluzione del mio rapporto con la letteratura a cambiare la maniera in cui traduco.
10) Si ha ancora paura del traduttore? L’editore ha modificato il suo rapporto con il traduttore?
Sì e no. In parte – soprattutto, voglio ripeterlo, grazie al lavoro dell’ultima generazione di traduttrici e traduttori – si riconosce l’enorme potenzialità di ricchezza insita in questa figura, dal punto di vista dell’arte, della scoperta di nuove scritture (a volte di nuove letterature, addirittura) e perfino – perché no? – del marketing. Ma devo dire che molto spesso c’è ancora una grande insofferenza verso la sacrosanta volontà di traduttrici e traduttori di avere più voce in capitolo all’interno dell’industria editoriale. Questo è evidenziato soprattutto nelle pubblicazioni ufficiali dell’Aie (l’Associazione italiana editori) in cui ormai da un lustro si dà sempre meno spazio a cifre e riflessioni sulla traduzione, che invece fino al 2015-16 vi occupavano una posizione abbastanza centrale. Del resto si capisce, le gerarchie non amano gli scossoni. E invece gli scossoni sono salutari. Anche per le gerarchie.
11) Cosa ci siamo persi sinora mancando di tradurre dei libri considerati importanti nella letteratura lusofona?
Ah, be’, due o tre universi. Le lusofonie comprendono il Brasile classico e contemporaneo, un paio almeno di letterature africane, perfino qualche pillola asiatica. Per non parlare del Portogallo contemporaneo, questo sconosciuto. Ma la cosa più grave è la mancanza di un progetto con un minimo di sistematicità. Se pubblichiamo un libro ogni lustro, preso un po’ da qui e un po’ da lì nel tempo e nello spazio, il pubblico di lettori anche forti faticherà a formarsi non dico un gusto ma anche solo un minimo di cognizioni di causa.
Però questo non riguarda solo le lusofonie, va detto. Oggi viviamo sotto una dittatura editoriale angloamericana, e anche molto ristretta quanto a generi e stili. Tutti gli altri soffrono. O meglio, soffrono i lettori per mancanza di scelta. Infatti si stufano e leggono di meno. Diamogli più varietà e sono sicuro che col tempo le percentuali migliorano. Certo, bisogna eliminare i manager dalle case editrici. Ci vuole un nuovo Giulio Einaudi, ché dei Briatore sinceramente non sappiamo che farcene.
12) C’è ancora spazio per le cosiddette letterature “minori”? Qual è il margine effettivo che viene offerto alle traduzioni di libri che non siano di tradizione anglosassone?
È presto detto: secondo l’ultimo rapporto Aie le traduzioni in Italia rappresentano ormai da anni il 12,5% del totale (all’inizio del secolo erano il 25%, nel 2015 rappresentavano ancora il 17,7%) e il 58,5% sono dall’inglese. Da quest’ultimo punto di vista siamo migliorati: tra il 2005 e il 2014 le traduzioni dall’inglese erano il 61,8% del totale, sempre secondo fonti Aie. Ma è ancora un monopolio culturale. Dobbiamo fare di più. Mica per le letterature “minori”: per noi stessi.